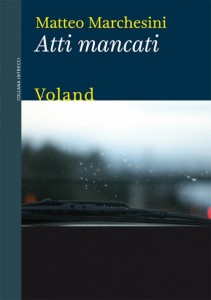 Due cose, come altre, possono sorprendere il lettore che si accosta a questo romanzo breve di un autore giovane com’è Matteo Marchesini: una struttura ben definita in ogni particolare, che funziona come un meccanismo ad orologeria (ma da cui, nello stesso tempo, non s’emana nessun indizio di artefatto) e la totale assenza di ammiccamenti stilistici riconoscibili (siano essi spasmi liricheggianti, anacoluti parodianti il parlato o periodi brevi e neutrali, da corso di scrittura creativa ad alto livello); lo stesso “tu” della prima pagina è un “tu” che non strizza l’occhio al lettore, ma che introduce, semmai, in presa diretta, alle ragioni del dramma. A ben vedere, il “peccato originale” del protagonista, Marco Molinari, è tutto in questa densissima prima pagina, che forse non sarebbe stata male in corsivo. Un peccato originale, appunto, inscindibile da una necessità che s’è fatta strada in lui in un tempo e per ragioni impossibili da ricordare. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di una non astratta incapacità di misurarsi con la vita, se non dietro la lente protettiva dell’arte, della scrittura. Non siamo però, e questo occorre dirlo, al solito, novecentesco, “male di vivere”. Il suo muto dolore non è mai messo in relazione con un presunto Spirito del Tempo. Quello che si limita a fare Marco, come intellettuale e come scrittore, è prenderne atto. Prendere atto della sua solitudine, senza tuttavia costruirci sopra auto-mitizzazioni, borghesi vittimismi (autore e protagonista non direbbero mai di essere vissuti al cinque-per-cento!) o neoromantici titanismi.
Due cose, come altre, possono sorprendere il lettore che si accosta a questo romanzo breve di un autore giovane com’è Matteo Marchesini: una struttura ben definita in ogni particolare, che funziona come un meccanismo ad orologeria (ma da cui, nello stesso tempo, non s’emana nessun indizio di artefatto) e la totale assenza di ammiccamenti stilistici riconoscibili (siano essi spasmi liricheggianti, anacoluti parodianti il parlato o periodi brevi e neutrali, da corso di scrittura creativa ad alto livello); lo stesso “tu” della prima pagina è un “tu” che non strizza l’occhio al lettore, ma che introduce, semmai, in presa diretta, alle ragioni del dramma. A ben vedere, il “peccato originale” del protagonista, Marco Molinari, è tutto in questa densissima prima pagina, che forse non sarebbe stata male in corsivo. Un peccato originale, appunto, inscindibile da una necessità che s’è fatta strada in lui in un tempo e per ragioni impossibili da ricordare. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di una non astratta incapacità di misurarsi con la vita, se non dietro la lente protettiva dell’arte, della scrittura. Non siamo però, e questo occorre dirlo, al solito, novecentesco, “male di vivere”. Il suo muto dolore non è mai messo in relazione con un presunto Spirito del Tempo. Quello che si limita a fare Marco, come intellettuale e come scrittore, è prenderne atto. Prendere atto della sua solitudine, senza tuttavia costruirci sopra auto-mitizzazioni, borghesi vittimismi (autore e protagonista non direbbero mai di essere vissuti al cinque-per-cento!) o neoromantici titanismi.
Ma con la scrittura – e questo è il primo, decisivo dubbio del protagonista – è possibile barare? La finzione, certo, anche senza fughe, può essere un temporaneo rimedio, così come il passato si può ricostruire a proprio piacimento – da vincitori o da sconfitti poco importa. Ma cosa succede se ci si trova costretti a vivere una proroga di analisi, di riflessione?
Ecco allora che nell’asettica vita di Molinari, intellettuale bolognese impegnato a scrivere sui quotidiani (cercando di non piegarsi totalmente a ragioni redazionali), fa la sua ricomparsa Lucia, la ragazza che, anni prima e senza dare spiegazioni, lo ha lasciato – facendolo piombare in un dolore sordo. Da subito, lei lo trascina a forza (ma è una forza che pare scaturire da una cocciuta debolezza infantile) verso i luoghi e le persone del loro passato. Si insinua poi, in questa strana coppia, il terzo elemento di un comune amico deceduto, Ernesto. È una presenza-assenza costante per tutto il romanzo e che trova il suo terreno riverbero nella figura del fratello Davide, vivo, ma separato dai vivi dalla cortina d’una presunta infermità mentale. In questo scenario fatto di pochi personaggi (ma tutti decisivi nell’economia del testo), c’è posto ancora per la figura di un non più giovane critico letterario, Bernardo Pagi (impossibile non vederci un ritratto di Alfonso Berardinelli), che funziona qui come trait d’union tra Marco e Lucia, ma anche come idolo mobile di fronte a cui Marco può esibire conquiste e differenze in ordine di pensiero e carattere.
Lucia, in cui Marchesini racchiude sociologicamente certi tratti di una piccolo-borghesia bolognese da lui indagata, in veste di scrittore, in numerosi corsivi usciti sulle pagine del «Corriere di Bologna» negli ultimi anni, e ricompresi in parte nel libro Bologna in corsivo. Una città fatta a pezzi (Pendragon 2010), è forse l’ultima guida possibile per affrontare e concludere quel non-finito di vita e di arte (Marco Molinari è alle prese con un moncone di romanzo che non riesce a terminare).
Non è chiaro, inizialmente, ciò che Lucia gli sta chiedendo. A lui, che con stordita arrendevolezza si lascia trascinare nei loro luoghi “storici” (e anche in quella Villa Baruzziana dove passa le sue ore Davide, poco distante dal luogo in cui il fratello Ernesto si è andato a schiantare con l’auto), in un passato che avrebbe forse preferito ignorare. Eppure, nella lucidità analitica del protagonista, sussiste una forma di precoce presbiopia che gli impedisce di notare, fin oltre i limiti del possibile, l’evidenza che si trova sotto i suoi occhi, ovvero ciò che di nuovo è intervenuto nella vita della ragazza – in più momenti Molinari sembra una personaggio, tozzianamente, con gli occhi chiusi.
E tra un centro di Bologna reso con pochi tratti decisi, una pianura mai liricizzata, un paesaggio appenninico ordinatamente severo, scorre il resto di questa storia, in cui tutto sembra svelarsi a poco a poco.
Marchesini, pur utilizzando strumenti che gli vengono dalle molteplici sfaccettature dei suoi, plurali, generi di scrittura, che egli alterna – come lui stesso ha ammesso, con un paragone felice – come colture in una rotazione triennale, dimostra di possedere già gli strumenti necessari per la redazione di un romanzo. Nello stesso tempo, non ignora tutte quelle aporie che tale genere ha mostrato già dalla seconda metà del Novecento. In queste pagine senza fronzoli, ma densissime, quasi laviche (e in cui è netto il rifiuto per una lingua sterilmente scorciata e resa commercialmente fruibile, com’è in molti giovani scrittori italiani, loro sì piegati alle esigenze editoriali o semplicemente ricostruiti a tavolino) risulta chiaro ciò che si vuole evitare: niente sofisticherie oltre i limiti, niente dimostrazioni di slealtà verso il lettore per mezzo di attraversamenti e riattraversamenti camuffati dei confini dell’immaginario. Niente giochi alla Borges, insomma. Se una riflessione meta-letteraria c’è, essa è costruita su quanto di più reale può esservi: il romanzo incompiuto di un amico morto (incompiuto come la sua vita) e quello che ha ancora una possibilità di essere terminato (il “moncone” di Marco), una volta che si è giunti a conoscere ed espiare fino infondo le ragioni del proprio dolore.
Se poi, sussistono dei ponti tra l’attività di Marchesini come saggista, corsivista satirico, polemista, critico militante e poeta, questi sono soltanto nell’ordine dei contenuti. I vasi sono comunicanti, certo, ma indipendenti.
Quello che si segnala, semmai, è un eccesso di analisi. Marchesini sembra volerci sempre spiegare tutto, sembra voler sciogliere, uno a uno, tutti i possibili nodi. Nei suoi personaggi – e qui, si sente a volte l’acribia del saggista, e un carattere bulimico e sempre a rischio d’asma – non c’è mistero. Sono aggirabili come statue, non si sottraggono in nessuna loro parte all’occhio lucido dello scrittore (e dunque anche del lettore). “Il dorso delle cose”, come lo chiamava Ernst Bloch, è continuamente mostrato, ma senza impudicizia, senza che si gridi ogni volta al Re nudo.
Lo stessa ambiguità di Davide, in bilico tra un esserci e un farci, non è enfatizzata; semmai la sua follia costringe a un fisiologico, a un naturale passo indietro nella comprensione.
Si può vedere, di questo atteggiamento “anti-mistificatorio”, un esempio concreto. Nella scena ambientata a Villa Baruzziana, a un certo punto, il “matto” Davide si lascia andare a una confidenza (siamo a p. 73). Con la sua vocetta metallica alla Carmelo Bene, racconta all’attentissima Lucia e all’irritato Marco, di uno scherzo che ama ripetere, quando può, ai danni di una paziente. Questa donna, ospite come lui della Villa, si muove come un pendolo tra due tigli. Davide, aspettando il momento buono, le si mette innanzi facendola sbilanciare contro uno degli alberi.
Questa caratterizzazione di un psicosi non è fine a se stessa, ma trova, molto più avanti (siamo alle pp. 112-113), una ragione più generale nell’economia del romanzo. Se quella mossa disorientante, se quello scherzetto un po’ sadico avesse trovato una dimensione ben più tragica al momento della morte di Ernesto, andato a schiantarsi poco oltre il perimetro della Villa? Se Davide, insomma, avesse provocato la morte del fratello?
È Marco, il protagonista, a fare questa congettura, ispirato da alcune parole di Lucia che vogliono rappresentare la loro passata situazione di coppia, poco prima che tutto finisse. Ma è naturalmente l’autore, Matteo Marchesini, ad aver confezionato questo parallelo fortemente simbolico e potenzialmente rilevatore. Poteva scegliere di non dire niente, facendo in modo che le eloquenti parole di Lucia fossero dal lettore, autonomamente (forse anche automaticamente), associate all’episodio raccontato da Davide – e i critici si sarebbero sentiti, di certo, più potenti! Ma non l’ha fatto, e non l’ha fatto, noi crediamo, non soltanto per ragioni di artificio letterario, ma perché lui per primo conosceva il meccanismo che aveva intenzionalmente costruito. Non ha voluto tacere, smascherandosi da solo come un mago che estrae un coniglio e poi corre a mostrare il trucco.
Ora, è chiaro che la scrittura anti-ellittica di Marchesini, nello stile quanto nei contenuti, è una presa di posizione. Come tale può incontrare o meno il gusto di ciascuno, provocare insoddisfazione o persino irritazione. Il suo realismo non cerca particolari stonati, sembra voler eliminare ogni incertezza proprio là dove tutto appare più difficile. Il mistero, semmai, permane soltanto come non spiegato, come ancora da spiegare (oltre a quelle colonne d’Ercole, insomma, dove ancora non si è giunti), in quegli atti mancati colpevoli come un’omissione di soccorso, anche verso se stessi.

No responses yet